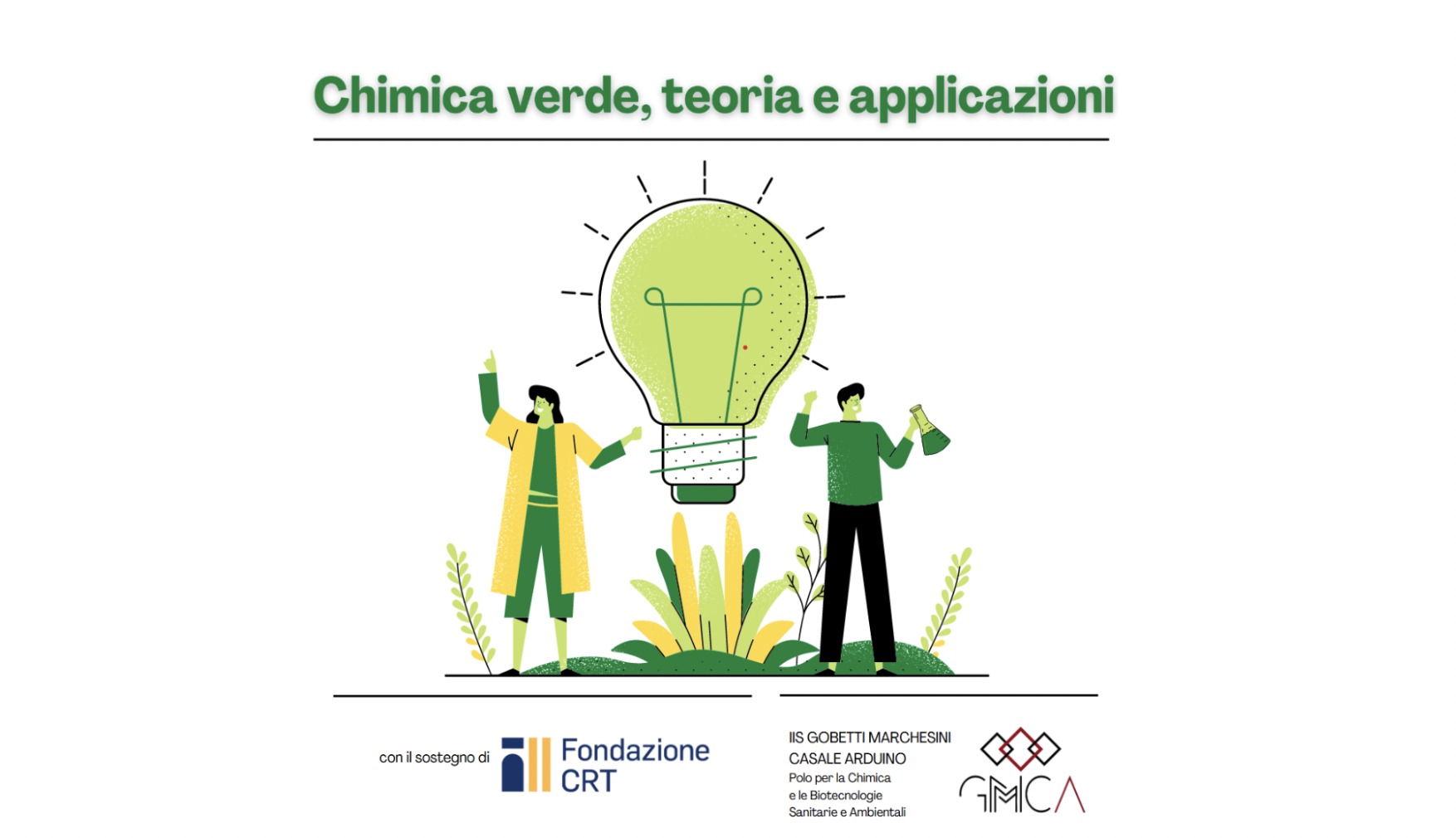La Chimica nel XXI Secolo
Giancarlo Cravotto
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - Università degli Studi di Torino
La chimica è una disciplina con una lunghissima storia risalente alle antiche civiltà (Egizi, Greci, Cinesi ecc.). La chimica moderna iniziò ad emergere dall'alchimia nel XVII e XVIII secolo, grazie a scienziati come Boyle, Lavoisier e poi Avogadro. Questi scienziati crearono le basi per gli straordinari progressi nei due secoli successivi. Ciononostante nel XX secolo nell’immaginario collettivo la chimica è stata progressivamente associata ad un’accezione negativa. La risonanza mediatica di alcuni disastri ambientali causati dall’industria chimica (es. Bhopal 1984) o di alcuni prodotti chimici (es. DDT, p-diclorodifeniltricloroetano) o ancora i terribili effetti collaterali di alcuni farmaci (es. talidomide), hanno disegnato il volto di una chimica matrigna. Solo l’avvento dei principi di “Green Chemistry” e “Green Engineering” e successivamente “Green Extraction”, ha potuto in parte riabilitare lo storico prestigio della chimica. Siccome la scienza si esprime con numeri, il nuovo corso della chimica verde ha sviluppato fin dai primi anni ’90 delle metriche per quantificare l’impatto ambientale e la sostenibilità del processo. Fra queste il cosiddetto E-Factor (Environmental Factor) ovvero il rapporto di kg di rifiuti/kg di prodotto, estremamente alto nell’industria farmaceutica (25-100) e nell’industria della chimica fine (5-50) che ne è il principale fornitore. La somma dei due fattori documenta il notevole impatto ambientale del farmaceutico, in particolare per l’elevato uso di solventi organici. Altra metrica importante per la sintesi organica è l'economia atomica (peso molare del prodotto/somma dei pesi molari dei materiali di partenza) con la situazione ottimale in cui tutti gli atomi dei reagenti confluiscono nella molecola sintetizzata. Una visione più ampia ed obbiettiva è offerta dalla valutazione del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) definita come l'analisi sistematica dei potenziali impatti ambientali di prodotti o servizi durante il loro intero ciclo di vita. I valori di LCA sono altresì un indicatore per valutare anche la fattibilità economica. È quindi maturato il concetto “cradle-to-cradle” dove l’obsolescenza di un prodotto non è un fine vita ma la trasformazione per un nuovo utilizzo, la sua rinascita. Vanno quindi analizzate tutte le fasi della vita di un prodotto, dall'estrazione delle materie prime alla lavorazione, produzione, distribuzione ed il futuro riciclo.
Innovazione
Fra le parole chiave riportate nelle riviste scientifiche ed in quelle di carattere divulgativo troviamo: innovazione ed invenzione. Spesso si evidenzia un uso improprio di questi due vocaboli che non sono sinonimi. Solo poche invenzioni passano dal prototipo ad un modello o processo pilota e quindi alla commercializzazione della realizzazione industriale. Non tutte le innovazioni richiedono una nuova invenzione bensì l'attuazione pratica di una idea nuova o migliorata per avere un impatto significativo sul mercato o sulla società. Thomas Edison (1847-1931) fu sicuramente un grande inventore così come in tempi più recenti Steve Jobs (1955-2011) un fantastico innovatore. Alfred Nobel (1833-1896) è) fu inventore ed innovatore e come Edison e Jobs anche imprenditore. Questi eclettici creatori hanno saputo trasformare idee ed invenzioni in processi industriali, in servizi ed in oggetti richiesti dalla società. In questo contesto va citato un ingegnere chimico piemontese visionario e poliedrico. Si tratta dell’imprenditore ed intellettuale Adriano Olivetti (1901-1960) che conquistò il mondo con le macchine da scrivere portatili fino al il primo computer a transistor da scrivania prodotto a Ivrea e poi usato dalla NASA per la missione Apollo 11. Olivetti cambiò le regole della produzione industriale, anticipando i tempi e disegnando una fabbrica a misura d’uomo dimostrando nei fatti che progettare a misura d’uomo è ciò che permette all’umanità di giungere a mete prima ritenute inarrivabili. Uno scienziato visionario ed innovatore in ambito chimico, fu senz’altro Giacomo Ciamician (1857-1922) considerato il padre della fotochimica e dei pannelli solari; sono infatti famose le foto del suo laboratorio sul terrazzo del dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna (Fig. 1).
Fig. 1. Esperimenti fotochimici di Giacomo Ciamician con la luce del sole.
2. Tecnologia
Nel 2019 una ricerca della IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) condotta da un pool di esperti internazionali dei vari settori della chimica, ha pubblicato le "Top Ten Emerging Technologies in Chemistry". Dato il grande interesse suscitato, lo studio ebbe negli anni successivi vari aggiornamenti. Le cosiddette “Enabling Technologies” stanno rivoluzionando i processi dell’industria chimica e non solo. Fra questi la “Flow Chemistry” ovvero la sintesi chimica in reattori a flusso continuo dai micro-channels fino ai meso-channels di dimensione millimetrica. Questa tecnologia grazie alla elevata superficie di contatto permette un perfetto scambio termico ed una buona miscelazione, nonché un preciso controllo di tutti i parametri sintetici.
Il riscaldamento e la miscelazione tradizionali nei reattori batch non sono più competitivi con i metodi sintetici a flusso continuo. Il flusso permette di associare tecnologie di intensificazione di processo che possono promuovere fortemente la cinetica di reazione (ultrasuoni, cavitazione idrodinamica ecc.). Fra le “Top Ten Emerging Technologies” della ricerca IUPAC apparivano i “Reactive extruders”. Questa tecnologia si inserisce nella meccanochimica condotta in varie tipologie di mulini in genere senza solvente (Fig. 2). A differenza delle procedure batch dei mulini, gli estrusori permettono di condurre reazioni chimiche su solidi a flusso-continuo senza solvente (Fig. 3).
Fig. 2. Mulini planetari per reazioni meccanochimiche (DSTF, Torino).
Fig. 3. Microestrusore reattivo (DSTF, Torino).
Entrambe le figure documentano tecnologie molto diverse dai classici reattori in Pyrex usati nei laboratori di sintesi chimica. Due esempi di intensificazione di processo che possono miniaturizzare la produzione e semplificare il downstream ovvero le operazioni per isolare il prodotto sintetizzato.
Nell'attuale rivoluzione dell'Industria 4.0, i nuovi progressi basati su sistemi informatici di ultima generazione, di realtà aumentata, di intelligenza artificiale saranno in grado di ottimizzare e standardizzare i processi sintetici collegando i reattori a cascata con il monitoraggio continuo in linea e persino prevedere soluzioni in caso di eventi imprevisti. Fonti di energia alternative, come il riscaldamento dielettrico ed ohmico, il plasma e l’irradiazione con LED hanno rivoluzionato le procedure standard. Degne di nota sono anche le cosiddette tecniche ibride, dove la combinazione di due diverse fonti di energia genera spesso effetti sinergici.
3. Sostenibilità
La valutazione della sostenibilità della produzione di sostanze chimiche ha stimolato nell’ultimo decennio un importante filone di ricerca che riguarda l’utilizzo di fonti rinnovabili come le biomasse. Lo sviluppo di una produzione biologica sostenibile di sostanze chimiche si sposa bene con il concetto di economia circolare, basata sull'efficienza delle risorse e sulla minimizzazione dei rifiuti in base alla progettazione, per sostituire la tradizionale economia lineare “prendi-usa-smaltisci”. La responsabilità sociale di un gruppo industriale deve coniugare aspetti sociali, ambientali ed economici. Questi tre aspetti forniscono la base per la regola dele 3 P: Persone, Pianeta e Profitto, un equilibrio che si incarna perfettamente nella green chemistry.
4. Insegnamento
Guardando al futuro ed alle nuove generazioni di chimici cosa potremo attenderci? Sicuramente una ricerca chimica sempre più inter- e transdisciplinare in grado di rispondere alle grandi sfide del XXI secolo. Le nuove tecnologie integrate della green chemistry e le applicazione industriali sono indispensabili per uno sviluppo sostenibile. Finora il ruolo delle scienze chimiche è stato sottovalutato e per colmare questa lacuna e promuovere la chimica per la sostenibilità nel suo complesso è necessario formare professionisti altamente qualificati. La rapidissima evoluzione scientifica e tecnologica tuttavia richiede un aggiornamento del corpo docente di scuola ed università, e una revisione visionaria dei programmi che includa tutte quelle conoscenze richieste dall’Industria 4.0 e dalla green economy. Non è facile immaginare le competenze che saranno richieste ad un chimico fra un decennio, poiché oggi tali professionalità sono solo in previsione. Un approccio internazionale con programmi condivisi come le iniziative dell'UNESCO per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile potranno accelerare questa transizione.
Fig. 4. Nuovi corsi di aggiornamento dei docenti della scuola secondaria sui temi di chimica verde
1. Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press: New York, 1998, p.30.
2.Anastas, P.T., and Zimmerman, J.B., Design through the Twelve Principles of Green Engineering, Env. Sci. and Tech., 2003, 37, 94A-101A.
3. Chemat, F.; Abert-Vian, M.; Cravotto, G. Review: Green Extraction of Natural Products: Concept and Principles.
4. https://chimica.unibo.it/it/dipartimento/presentazione/storia-del-dipartimento
5. Grillo, G.; Manzoli, M.; Bucciol, F.; Tabasso, S.; Tabanelli, T.; Cavani, F.; Cravotto, G. Hydrogenation of levulinic acid to γ-valerolactone via green microwave-assisted reactions either in continuous flow or solvent-free batch processes. Ind. Eng. Chem. Res. 2021, 60 (46), 16756-16768.
6. Martina, K.; Tagliapietra, S.; Barge, A.; Cravotto, G.; Combined Microwaves/Ultrasound, A Hybrid Technology, Top. Curr. Chem. 2016, 374, 79.
7. Calcio Gaudino, E.; Grillo, G.; Manzoli, M.; Tabasso, S.; Maccagnan, S.; Cravotto, G. Mechanochemical applications of reactive extrusion from organic synthesis to catalytic and active materials. Molecules 2022, 27(2), 449.
8. Tagliapietra, S.; Calcio Gaudino, E.; Martina, K.; Barge, A.; Cravotto, G.; Microwave irradiation in micro- meso-fluidic systems; hybrid technology has issued the challenge. Chemical Record 2019, 19(1), 98-117.